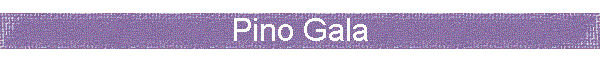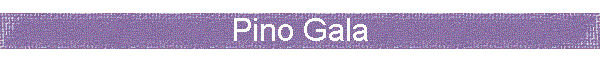Da questo pulpito mediatico
si è più volte “tuonato” contro la situazione revivalistica della danza
tradizionale in Italia. Poco interesse ad approfondimenti da parte degli
amanti del ballo, poca professionalità da parte degli insegnanti, spesso
più impegnati in attività d’animazione che di trasmissione culturale.
Certo, con molte eccezioni. Ma non sufficienti per evitarci di scuotere
colpevolmente la testa di fronte alle accuse velate di ricercatori che si
rendono conto di non riuscire a incidere, se non con il proprio
insegnamento, sulle superficiali nozioni comuni della danza e della
cultura tradizionale.
Sia chiaro che non stiamo invitando ogni insegnante ad investire il
neofita curioso, al suo primo corso di base, con preliminari conferenze su
singoli aspetti di singoli repertori.
Né vogliamo confondere revivalismo e pratica della danza, le esigenze di
un ballerino delle valli occitane impegnato in una curento e quelle di un
milanese gettato nella mischia di una tarantella di Montemarano. Non
vogliamo, né potremmo, criticare il revivalismo come fenomeno di massa
(Quali masse? Dove le avete messe?).
Solo cerchiamo, di fronte ad una forbice, le cui gambe vanno
dall’animazione alla cultura, di avvicinare gli estremi, di renderli
funzionali l’uno all’altro, di interrogarci sugli obiettivi, di aumentare
la comunicazione e l’interesse verso una tradizione che ha una storia e
una funzionalità da conoscere.
Con queste intenzioni ci
impegniamo a portare in questo giornale la voce di alcuni ricercatori
italiani e stranieri, come in parte già fatto con Yvon Guilcher, i
Brayauds,...
Iniziamo oggi con un
intervista a Pino Gala, incontrato qualche mese fa a Torre Pellice,
continueremo, speriamo già nel prossimo numero, con il resoconto di una
interessante chiacchierata con Dina Staro.
D. La ricerca
etnocoreutica, cioè relativa alla danza tradizionale, è per gli
appassionati di danza qualcosa di assai poco conosciuto.
R. Per i più la ricerca
non esiste proprio, non ne sono assolutamente condizionati.
Molti in Italia ti conoscono. Molto probabilmente più per i tuoi corsi ad
Estadanza che non per le tue ricerche o per i tuoi articoli su Choreola.
D. Qual è il
problema, secondo te ? Il mondo del revival è troppo superficiale per
porsi domande e per avvertire esigenze ? O la ricerca non ha avuto voce
sufficiente forza, capacità per arrivare alle orecchie e alle menti dei
danzatori?
R. E’ un problema
complesso.
In altre discipline la ricerca spesso è una cosa a se stante rispetto alla
fruizione, alla divulgazione: il ricercatore fa il suo lavoro, analizza,
studia, cataloga, fa tutta una serie di operazioni che sono il suo
mestiere.
In Italia, nel campo delle danze etniche, è successo un fenomeno
abbastanza particolare, anche se non del tutto originale.
Intanto, per inciso, la paura dei ritardi è un problema che ci accomuna a
molti altri stati...
D. Paura dei
ritardi, in che senso?
R. Paura di essere in
ritardo con la documentazione. Ci sono anche stati molto più avanti di
noi, con archivi ben forniti, materiali catalogati e, spesso, pronti per
esser consultati.
In Italia la ricerca è partita in modo più volontaristico.
Proprio qui, probabilmente, è il tallone d’Achille della questione:
l’operazione ricerca si è basata spesso sull’entusiasmo, sulla dedizione
di pochissimi ricercatori. Ricercatori con una preparazione autodidatta,
basata su errori, su un empirismo che cresceva giorno per giorno. Con
risultati spesso non definitivi, lenti, insufficienti.
Il disinteresse delle istituzioni, sia amministrative che accademiche, ha
fatto il resto obbligando, comunque, il ricercatore a lavorare
costantemente in sordina.
Un altro limite della ricerca è stato quello di voler legare subito i
frutti della ricerca all’utilizzazione pratica, revivalistica,
socializzante. Questo è stato condizionante: si trovavano dei materiali
nuovi e, prima di analizzarli compiutamente, si riproponevano. E’ mancato
da subito uno studio profondo e concentrato sul repertorio.
La visibilità di fatto non c’è stata e continua a non esserci,
semplicemente, come già detto, perché la ricerca non è istituzionalizzata.
Chiunque può partire, prendere una telecamera, andare in una festa in cui
vedere danze, recuperarle, documentarle. Questo non vuol dire fare
ricerca. Questo vuol dire solo esplorare, fare dei sopralluoghi. Si può
parlare di ricerca solo quando una persona entra nell’ottica di dedicare
parte del suo tempo, spesso gran parte, a questa operazione.
Purtroppo non è stato benefica una certa mania esterofila : la gente viene
proiettata verso balli stranieri, di moda, e non si interessa al
patrimonio etnocoreutico delle proprie zone di provenienza o di vita.
D: Mi hai
spiegato i problemi della ricerca, ma, continuando sul tasto della
provocatoria sensazione d’assenza di queste problematiche nel mondo
revivalistico, oggi esiste una ricerca etnocoreutica in Italia? Una
ricerca che non sia legata a fenomeni estemporanei?
Ed esistono dei modelli, nel passato, di ricercatori etnocoreutici
italiani?
R: Alla prima domanda ti
posso rispondere con le notizie che ho.
Ci sono persone che hanno fatto ricerca in passato e poi si sono fermate.
Altre che hanno continuato e continuano ancor oggi a occuparsene da un
punto di vista culturale e scientifico. Ci sono invece dei nuovi arrivi,
pochi purtroppo, di cui ancora non sappiamo bene se si potrà parlare di
vere e proprie ricerche.
Ci sono anche persone, ne conosco diverse, che vanno sul luogo di pratica
della danza, filmano o registrano e, poi, conservano questo materiale.
Alcune finalizzano questa esperienza sul campo soltanto alla
riproposizione delle danze filmate. Questo ci priva di figure che possano
studiare le danze!
Ti faccio un esempio. Quando io ho bisogno di articoli per la rivista
Choreola, articoli relativi a esperienze di ricerca o di analisi, faccio
una grande fatica a trovare persone che sanno scrivere o quantomeno
finalizzano la loro esperienza ad uno scritto meditato.
Se, invece, voglio trovare persone che hanno visto dei balli, che li hanno
filmati e li vogliono insegnare, allora non ho problemi.
Ma un ricercatore non deve solo raccogliere, deve capire il fenomeno che
ha davanti, deve poterlo analizzare. Dietro al singolo fenomeno specifico,
il singolo ballo o repertorio, c’è tutto un mondo, non solo etnocoreutico
ma anche antropologico.
Per quanto riguarda i modelli di riferimento, in Italia non abbiamo
esperienze significative di ricerche sulla danza popolare fino agli anni
‘70. Abbiamo filmati sul repertorio delle “quattro province” o sul
carnevale di Bagolino, ma questi non possono essere considerati in sé
modelli di ricerca specifica, si muovevano anche all’interno di altre
ottiche. In Italia mancano modelli di riferimento come, ad esempio, in
Francia J.M.Guilcher...
D: Ce ne sono
forse più in ambito etno-musicologico....
R: Infatti io mi sento,
in questo senso, un po’ figlio di Diego Carpitella, che ha seguito per
alcuni anni. Carpitella, che tra le altre cose ha insegnato anche storia
della danza, aveva un interesse particolare per il mondo coreutico, era
prodigo di suggerimenti ed aveva partecipato con me a qualche ricerca sul
campo. Ho cercato di cogliere da lui quanto ho potuto.
D: Al di là dei
modelli, ho l’impressione che le persone che hanno fatto ricerca in modo
più continuativo in Italia siate tu e Dina Staro...
R: Sì, forse oggi le
persone che possono fare da punto di riferimento per altri ricercatori in
erba, sia da un punto di vista di studi, sia per capacità di analisi e di
teorizzazione, siamo noi. Siamo gli unici che abbiamo continuato ad
occuparci di queste cose in modo scientifico. E’ palese il desiderio di
fare entrare l’etnocoreologia in una vera forma di disciplina scientifica.
D: Molti lettori
credo che non abbiano alcuna idea di cosa sia la ricerca effettiva. Hai
già dato alcune indicazioni, hai parlato di analisi, di scienza, ma il
vero compito di un ricercatore qual é?
R: Credo che stiamo
uscendo, almeno io e la Dina, sperando di poter interpretare correttamente
il suo pensiero, da una corrente che in passato ha preso un po’ tutti: il
formalismo. Ci preoccupavamo di documentare la forma della danza, quindi
le strutture, i passi, i moduli, i movimenti, insomma gli elementi
formali. C’era, probabilmente, l’esigenza di fissare visivamente la forma
più che la sostanza della danza.
Generalmente una ricerca inizia con la scelta di un luogo ben preciso,
l’esplorazione del territorio, la conoscenza del repertorio di danze vivo
o in memoria, il recupero di questa memoria. Queste sono le prime due
fasi, la ricerca di informazioni e la documentazione del repertorio.
Quello che dovrebbe avvenire in seguito è l’approfondimento del contesto e
del mondo della tradizione popolare locale, della cultura che ha partorito
negli ultimi secoli quel dato repertorio documentato. Questo è una aspetto
della ricerca difficile ma intellettualmente gratificante.
E’ importante sottolineare che la danza etnica si differenzia dalle altre
forme di danza perché rimane ancorata a due colonne fondamentali: quella
del movimento della danza, dell’ arte coreutica in sé e quella relativa
alle conoscenze di tipo antropologico, etno-antropologico necessarie ad un
buon etnocoreologo per la propria formazione...
Bisogna tendere ad una antropologia della danza: la danza è frutto di una
cultura, non nasce da sé. Ciò che si sta diffondendo in Italia, invece, è
una concezione pedestre della danza: ci si interessa di come muovere i
piedi, dei passi... Ma questo è l’ultimo elemento da considerare. Anche
qui siamo in pieno consumismo.
D. L’indagine in
un territorio cosa presuppone? Chiedere agli anziani, farsi raccontare il
loro vissuto?
R. Un metodo d’indagine
deve rapportarsi al territorio scelto per la ricerca.
Io ho avuto fortuna. Nel ‘79 ho iniziato con le feste al Sud, con le
tarantate, allargandomi nell’analisi dei repertori coreutici, ma sempre
all’interno delle feste. Erano repertori in vita, che risentivano
positivamente di una linfa costituita da feste comunitarie, religiosità e
fenomeni cerimoniali...
In questo caso la metodologia presuppone una rielaborazione, una analisi
molto complessa che prevede una preparazione culturale ed intellettuale
consistente.
In altre zone, in Italia centrale, ad esempio in Umbria o nella Toscana
stessa, sapevo in partenza che il territorio era coreuticamente povero.
L’obiettivo diventava il recupero della memoria più che della pratica ed
esigeva tecniche diverse: dare importanza all’anziano, alla testimonianza
dei musicisti più che dei ballerini e, in certi casi, cercare la
responsabilizzazione, nella ricerca, degli enti pubblici,
dell’amministrazione, della Pro loco.
D: Dunque è
importante, prima di gettarsi nel “campo”, avere elementi di conoscenza
del mondo culturale e sociale di cui si vuole studiare il repertorio
coreutico...
R: Sì, ci deve essere un
sopralluogo iniziale. E’ importante crearsi una bibliografia di ricerche
etnomusicologiche fatte in precedenza o, comunque, di riferimenti a
tradizioni presenti.
Ma, in alcuni casi, in posti di cui non si conosce molto, è possibile
iniziare una esplorazione pionieristica, battere tutti i paesi con
interviste, fare indagini che si sviluppino a catena: un musicista ti
manda da un altro musicista, un ballerino da un altro ballerino, fino a
far riemergere la memoria della danza.
D: Chi volesse
avvicinarsi al mondo della ricerca, ad una ricerca non spontaneistica ma
preparata, seria, cosa può fare?
R: Io ti potrei
rispondere con un desiderio che potrebbe anche essere un sogno
irrealizzabile.
Mi sono accorto che, attualmente, non possiamo aspettarci nulla
dall’università : i docenti vicini all’etnocoreologia non se la sentono,
secondo me giustamente, di considerarsi dei formatori della ricerca. Sanno
di essere stati sorpassati dall’esperienza di alcuni.
Il mio desiderio è quello di formare con la Dina una vera scuola di
ricerca. Non so sotto quale egida, ma saremmo le persone più indicate per
trasferire la nostra esperienza meditata ad altri. Il ricercatore deve
venire prima o poi formato. Si può anche formare da sé, come abbiamo fatto
in parte anche noialtri, ma non è semplice.
Anzi, vorrei dire un’altra cosa: non tutti possono diventare ricercatori.
Non perché ci voglia una particolare grazia divina, ma un ricercatore, per
arrivare a certi livelli, deve avere due caratteristiche: una buona
formazione culturale e grande disponibilità di tempo.
Una persona che non ha la preparazione, il tempo o, anche, i soldi da
dedicare alla ricerca, incontrerà degli ostacoli insormontabili.
Ricordiamoci che oggi la ricerca non è finanziata o lo è in modo molto
sporadico....
D: Il problema
del rapporto con gli enti pubblici può essere interessante... Perché sono
così sordi alle necessità della ricerca In Italia?
R: L’istituzione avrebbe
dovuto avere un ruolo molto importante, ma lo ha impedito il generale
disinteresse. A livello istituzionale alto, parlamentare, governativo, non
c’è ancora attenzione al recupero della nostra memoria, della cultura che
sta alle nostre radici.
Ma c’è un problema di fondo: la memoria vera non è vendibile e non porta
al fenomeno del consumismo. Vengono finanziate, spesso, operazioni che
hanno una ricaduta solo in ambito turistico o promozionale. Un altro
problema è che le istituzioni sono interessate solo al prodotto finale
della ricerca, alla pubblicazione o alla produzione sonora.
Molti giovani interessati alla ricerca e con una formazione solida, ad
esempio in Sardegna, si illudono di trovare finanziamenti senza
difficoltà. Ma pensare, oggi, ad una istituzione interessata a finanziare
all’origine una ricerca, è illusorio.
Devo ricevere un milione per una ricerca svolta in Toscana: è la prima
volta in vent’anni di esperienza. Certo, molto dipende dalle persone che
sono addette alla cultura nei vari ambiti amministrativi.
Credo che, finché non si avrà in Italia una cattedra di Etnocoreologia, la
danza rimarrà sempre peregrina, figlia di nessuno.
D: Non esiste un
problema di comunicazione anche all’interno del ristretto mondo dei
ricercatori?
R: Il carattere, il gene
del ricercatore è quello di lupo solitario... Quindi tende, di fatto, a
lavorare nel suo campo, con il suo metodo, con i suoi informatori ed
esecutori tradizionali. Difficilmente è ben visto lo scambio, il
confronto. Questo è un difetto diffuso non solamente in Italia. Non so
quanto possa consolare, ma è così.
Conosco un po’ la situazione in Grecia, Argentina, Spagna e Francia. In
alcuni paesi sono state create delle istituzioni complementari a quelle
accademiche, ad esempio alcuni Conservatori dediti allo studio delle
tradizioni popolari in Francia o alcuni centri di studio in Catalonia o
Grecia. Sono centri paralleli che partono già istituzionalizzati o che lo
diventano in seguito. Questa è stata la strada più praticata.
D: Ho assistito a
discussioni sulla politicizzazione del fenomeno della ricerca italiana nel
recente passato. Che giudizio ne dai a posteriori? Un bene o un male per
gli obiettivi di oggi?
R: Ma io complessivamente
lo giudico un bene. In mancanza di una istituzione che si occupasse della
tradizione, ci doveva essere una spinta che nascesse da altre parti. In
Italia, ma non solo in Italia, questa spinta è arrivata da una ideologia.
C’è stato, sicuramente, un errore di ottica. L’estrema ideologizzazione
della ricerca, o comunque dell’approccio alla ricerca, in Italia negli
anni ‘60 e ‘70 ha portato a selezionare a priori ed in maniera errata il
materiale che si andava a ricercare, scartando cose che poi sarebbero
potute servire.
Questa cosa, oggi, è superata. Si è capito che uno può tenersi le proprie
idee politiche senza viziare il lavoro con punti di vista preconcetti.
Oggi, ad esempio, c’è un grande interesse dell’etnomusicologia per tutto
quanto riguarda la musica sacra di tradizione orale.
Io stesso mi sono reso conto che se facevo ricerca in contesti festivi
religiosi, non potevo privare la danza del suo aspetto religioso senza
depauperarla e privarla di un sostegno fortissimo. E questa religiosità
non ha un colore specifico, è un bisogno umano, cui ci si può avvicinare
anche da laici.
D: C’è tra alcuni
ricercatori, specialmente d’oltralpe, l’opinione che non sia corretto
parlare di continuità della tradizione nelle nostre società moderne,
postindustriali ....
R: Considero questa tesi,
per certe aree, certi ambiti, fortemente sbagliata.
Abbiamo delle zone in Italia dove la danza non è stata mai smessa. Basta
pensare al Nuorese, a Montemarano, alle tarantelle dell’ Aspromonte...qui
la tradizione non è stata mai interrotta, almeno per quanto ne sappiamo.
D. Non è che
abbiano perso la loro funzione tradizionale?
R. Per un montemaranese
una tarantella, almeno quella processionale, la si fa in occasione del
Carnevale, non la balla in altre circostanze. Anzi loro si stupiscono
molto che la loro tarantella venga imparata e ballata altrove in
situazioni differenti. Il loro stupore è segno di una sorta di verginità.
Questo non significa, però, che la danza sia vista in una dimensione
statica: l’evoluzione c’è sempre stata e la tradizione, finché è viva, è
responsabile del proprio patrimonio. Magari in modo non del tutto
cosciente, ma ne è responsabile.
In Italia quindi esistono ancora delle situazioni di questo genere.
La differenza tra un Sud e un Nord, sempre generalizzando, è che nel Sud
ancora il revival non è così forte ed è addensato, per fortuna, solo in
alcune città. E dico per fortuna perché vedo le devastazioni che ci sono
state. Quando un settentrionale va a vedersi la Baio, il carnevale di
Bagolino, quello resiano, si fa una concezione particolare del folklore.
Crede che il folklore sia rinato grazie ad un interesse, una presa di
coscienza di qualcuno interno o esterno alla tradizione, senza pensare che
il modello più antico o arcaico è quello dove la tradizione è vissuta in
sé, senza una tensione esterna o, peggio, una manipolazione. Queste
esperienze si possono trovare anche in Italia. Sono, per me, i laboratori
d’osservazione più interessanti, più reali.
Possiamo paragonare, ad esempio, una festa dell’Aspromonte dove la
tarantella viene ballata in momenti festivi fortemente ritualizzati, con
codici di comportamento a volte anche ferrei, e una festa a Monghidoro,
dove la tradizione è stata “ripompata”.
Nell’80 quando grazie a Dina e al Cammelli, andavo lì si ricordavano tre o
quattro balli. Ora ne praticano ventiquattro. Non so si può parlare di
tradizione. C’è stata una cesura, non una presa di coscienza dall’interno.
I portatori o i nuovi portatori della tradizione non hanno rigestito il
loro patrimonio ma hanno avuto bisogno di un intervento esterno, di un
innesto artificiale.
Bisognerebbe aspettare e, tra duecento anni, vedere se queste forme di
innesto saranno passate e tramandate dalla gente del posto.
D. Dunque nel
Centro e nel Sud ci sono tradizioni che continuano e che non dipendono da
te o da chi come te fa ricerca...
R. Io evito di riproporre
alcune feste e alcune danze proprio perché sono patrimonio di piccole
comunità: la presenza estranea, anche di poche persone, snaturerebbe la
stessa festa o alcuni comportamenti di danza. A tal proposito, ho avuto
delle discussioni con altri ricercatori che rivendicavano il diritto alla
conoscenza, alla ricerca, ma, in questi casi, secondo me, deve prevalere
il diritto delle piccole comunità a preservarsi.
Una volta che questo patrimonio è conosciuto e divulgato, diviene oggetto
di attrazione e di curiosità. Si arriva a snaturare i comportamenti
rituali e il modo interno alla comunità di vivere la tradizione.
Questo e un problema grosso. Dunque, il ricercatore si deve porre un
problema etico riguardo la correttezza della trasmissione.
Spesso mi succede di terminare uno stage e di sentirmi frustrato,
amareggiato. In Piemonte, per esempio, ho fatto due stage di balli di
regioni lontane, uno durante la Settimana Santa e un altro nel week-end
dei Morti: nella tradizione questi sono periodi durante i quali non si
balla.
Esiste una concezione rituale della vita per cui ogni cosa ha il suo tempo
secondo un preciso ordine temporale e culturale. Il revival ha disfatto
questo ordine, inventandone uno suo, inventando ritmi e tempi propri.
Un ricercatore deve, dunque, porsi dei problemi etici.
Ci sono anche situazioni in cui la funzione del ricercatore torna nel suo
alveo più nobile e interessante, quello di far rivivere, con l’uso
dell’informazione solo filmata, la memoria dei padri, dei nonni, della
gente del posto. Il ricercatore quindi come tramite, conduttore, cavo
elettrico per far passare l’energia tra i vecchi, che non possono più
trasmettere, e i giovani.
D. In chiusura,
parlami della rivista “Choreola”
R. Proprio ultimamente
siamo venuti a conoscenza del fatto che “Choreola” è l’unica rivista al
mondo che si dedica alla danza etnica. Questo ci riempie di gioia e di
responsabilità allo stesso tempo.
Le altre due riviste “La ricerca della danza “ in Francia e “Folk Dance”
in Inghilterra non pubblicano più. Non so se in America ci sia qualcosa,
ma credo di no, a quanto mi hanno detto.
A parte ciò “Choreola” ha due problemi: uno finanziario, comune a tanta
riviste, ed uno tecnico, relativo alla penuria di ricercatori.
Eravamo partiti con l’idea della quadrimestralità, ci immaginavamo che
Pinna, Scarsellini, Castagna, Boschero avrebbero scritto... Invece questa
adesione è mancata e noi ci siamo trovati in difficoltà nel reperimento di
materiale da pubblicare.
Un altro problema è, invece, legato alla redazione : la rivista la
battiamo a macchina e la impaginiamo noi, nel nostro tempo libero, con
dispendio volontario di denaro e fatica.
Pur con queste difficoltà, comunque, continueremo, cercando, magari, di
non ripetere più errori quali l’impelagarsi in monografie,come la canzone
a ballo, che hanno portano via parecchio spazio e bloccato i numeri
antologici.
Io invito tutte le persone che si interessano alla danza tradizionale ad
entrare nell’ ottica della diffusione di questo
sapere coreutico: ”Choreola” potrebbe avere un ruolo educativo e di
formazione nell’ ambito revivalistico.